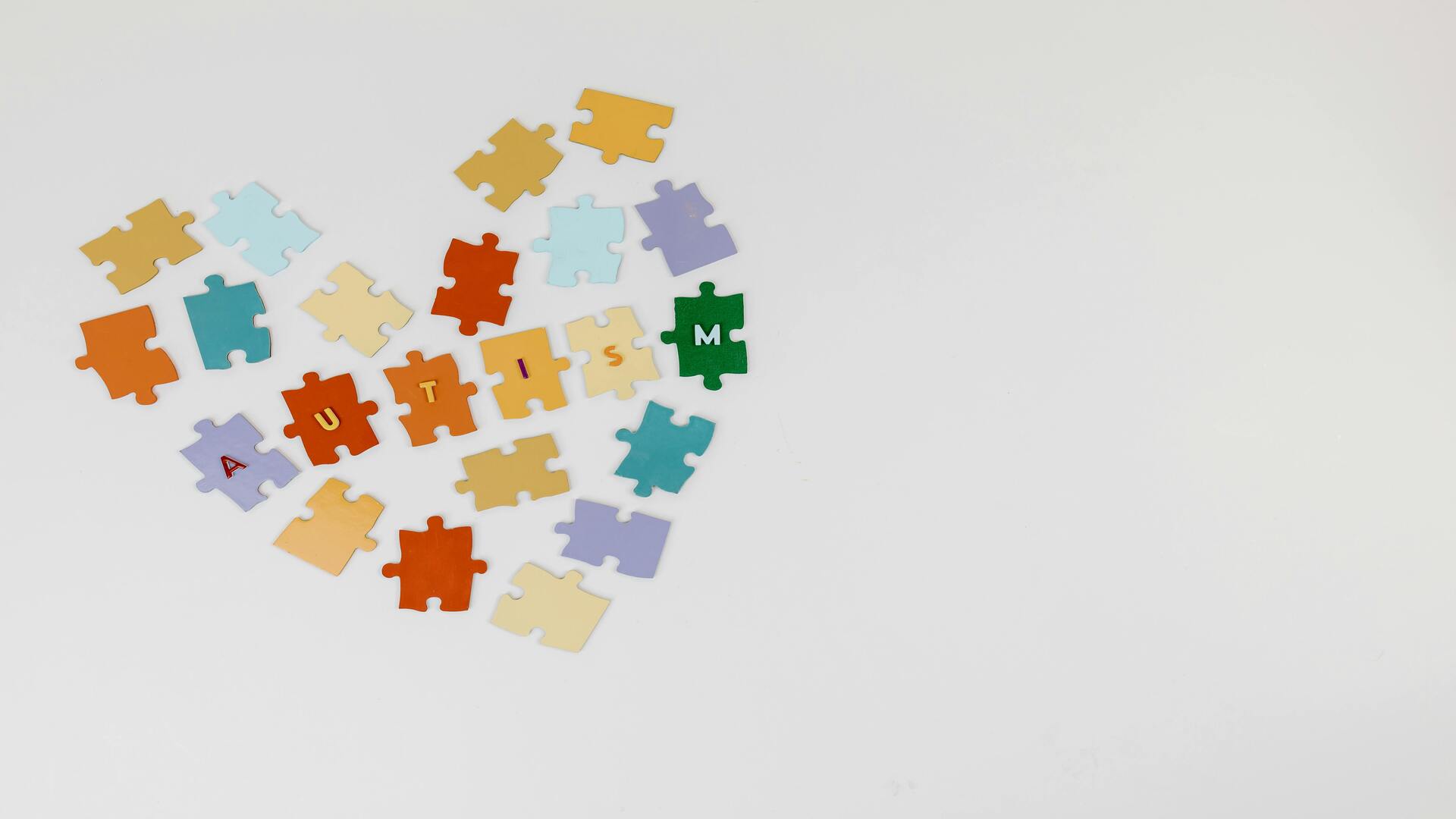Ieri era la Giornata Mondiale dell’autismo, oggi cosa rimane? Questo vale anche per le altre giornate mondiali: nonostante nascano per sensibilizzare su problematiche specifiche, il giorno dopo si continua a camminare sullo stesso sentiero. Lo scorso 22 marzo si è celebrata la giornata mondiale dell’acqua, ma ancora oggi quasi 2 miliardi di persone usano “fonti di acqua potabile contaminata da feci”. Eppure, si celebra la giornata mondiale dal 1992.
Nel concreto, bisogna parlare delle difficoltà e delle possibilità che queste giornate ci lasciano. Alla viglia della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, 90 associazioni di famiglie italiane con figli autistici si sono riunite per esprimere al ministro Valditara la necessità di potersi avvalere degli insegnanti di sostegno e delle cure mediche necessarie.
Leggi Anche
Basterebbe citare il caso di Palermo per capire che la situazione è ben più grave. A Palermo si ha difficoltà anche a ricevere le diagnosi e le cure: la pianta organica è ferma al 2020 ed era tarata per assistere 2500 pazienti. Dopo cinque anni i pazienti sono 5500 ed il personale resta il vero punto debole. Solo cinque i medici in prima linea chiamati a gestire i 4860 utenti in carico. L’azienda sanitaria di Palermo fa sapere che a breve dovrebbero arrivare due psichiatri, essenziali per la diagnosi, e che l’esigenza della copertura dei posti si scontra spesso con concorsi che vanno deserti.
Greta Scarano e la rappresentazione dell’autismo
Greta Scarano, in un importante momento personale, spiega al grande pubblico l’intento del suo ultimo film “La vita dei grandi”: “Volevo che emergesse forte e chiaro il punto di vista di Omar: il suo modo di vedere il mondo e le difficoltà di vivere con una disabilità e con il continuo confronto con una sorella ‘normale‘”.
La trama affronta le problematiche di una sorella e un fratello autistico, ma senza diventare il fulcro del racconto. “Nel film viene affrontata la questione della disabilità, ma per me era fondamentale che non fagocitasse tutto il racconto, esattamente come per il protagonista, il cui disagio è solo una delle tante caratteristiche che lo definiscono come persona“.
Nonostante la conoscenza dell’autismo abbia trovato un canale importante di divulgazione dei media, molte sono le critiche.
Da un lato, un pubblico più ampio ha il potenziale di aumentare la consapevolezza sul tema e dare uno slancio alle politiche di inclusione. Dall’altro lato, però, rappresentazioni imprecise o ristrette possono portare a perpetuare la disinformazione. Per questo motivo è necessaria una ricerca continua per esaminare le rappresentazioni dei DSA, cosa raccontano e cosa migliorare e dismettere per restituire sullo schermo la complessità di esperienze di vita autentiche.
Su “Autism in Adulthood” Sandra Lebenhagen della University of Calgary in Canada parla del problema della rappresentazione delle persone autistiche. Queste ultime, infatti, “riportano spesso che le loro esperienze vengono minimizzate o interpretate, seppur con buone intenzioni, da genitori non autistici, da ricercatori, educatori e alleati. Nonostante l’inclusione di voci autistiche stia migliorando persistono alcuni ostacoli, soprattutto nella ricerca con individui che possono essere descritti come non verbali o quasi non verbali“.
Per questo, non parleremo dei sintomi e come riconoscerli, perché vogliamo scrivere un articolo divulgativo e non un manuale diagnostico.
La rappresentazione dell’autismo nei media
I media hanno avuto un grande impatto sulla conoscenza dell’autismo. Pensiamo ai successi di serie tv come Atypical e The Good Doctor ma anche al film Rain Man, che è valso a Tom Cruise un Oscar. Eppure molto spesso, la narrazione sembra riduttiva e a volte priva di delicatezza e utilità, nonostante nasca con il nobile intento di de-stigmatizzare.
Ma il racconto televisivo, cinematografico e letterario tende a fare una cosa assolutamente essenziale della drammaturgia, ossia descrivere un personaggio. Come nel caso di Sam in Atypical e del dottor Shaun Murphy in The Good Doctor, tendenzialmente si tende a disegnare il soggetto come un uomo bianco, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, con abilità della sindrome del savant, ossia persone con capacità al di sopra della media o particolarmente talentuosi.
Però le persone autistiche sono sono tutte uguali e non hanno lo stesso patrimonio culturale, sociale ed economico. Per questo, una delle critiche maggiormente mosse dalle persone autistiche è che le rappresentazioni siano mosse da uno sguardo neurotipico.
Quindi, nella giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo dovremmo vedere le persone autistiche semplicemente come persone ma soprattutto ascoltare e comprendere la narrazione di loro stessi.
Che cos’è l’autismo?
Il 2 aprile è stata la Giornata mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, nata con l’obbiettivo di incentivare la comprensione della neuro diversità e porre l’attenzione sui diritti delle persone con autismo. Essendo la parola “autismo” un termine ombrello che comprende una enorme quantità di sindromi e manifestazioni cliniche differenti, la quantità di diagnosi è aumentata.
In Italia un bambino su 77 di età tra i 7 e i 9 anni presenta disturbi dello spettro autistico, con una prevalenza maggiore nei maschi. A livello mondiale, la statistica è di circa 1 su 54 bambini di 8 anni negli Stati Uniti, 1 su 160 in Danimarca e Svezia e 1 su 86 in Gran Bretagna.
Il nome corretto è disturbo dello spettro autistico ed è una neurodiversità, ossia la normale variabilità della mente umana in riferimento alle funzioni cognitive. La stessa parola “spettro” designa infatti l’enorme eterogeneità del disturbo stesso. Quindi, l’autismo non è una malattia e non ti colpisce né ne si è affetti.
Nel DSM-5, il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, è classificato tra i disturbi del neuro-sviluppo. Il termine “autismo” compare per la prima volta nel 1943 sulla rivista Pathology, grazie all’articolo “Autistic Disturbances of Affettive Contact” di Kanner, capostipite della psichiatria infantile americana. L’immagine descritta fu un bambino silenzioso, chiuso in sé stesso e indifferente all’altro.
Nello stesso periodo, in Europa, un altro medico ha utilizzato il termine “autismo” di Bleuer per descrivere un disturbo infantile dell’adattamento all’ambiente sociale. Il suo nome era Hans Asperger. Per questo l’autismo è spesso confuso con il disturbo Asperger.
La sindrome di Asperger condivide con l’autismo la presenza di compromissioni nelle abilità sociali, ma differisce dall’autismo per il fatto che le abilità linguistiche risultano ampiamente conservate e per un funzionamento cognitivo nella norma.
Nel DSM-5 l’autismo è caratterizzata da due componenti principali: una sociale, legata all’interazione e alla comunicazione sociale, e una non sociale, che riguarda il repertorio di attività e interessi.
© Riproduzione riservata